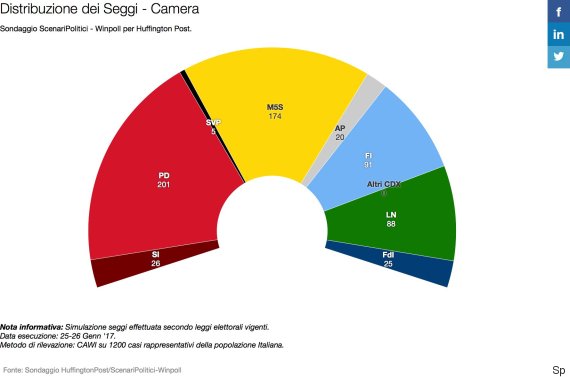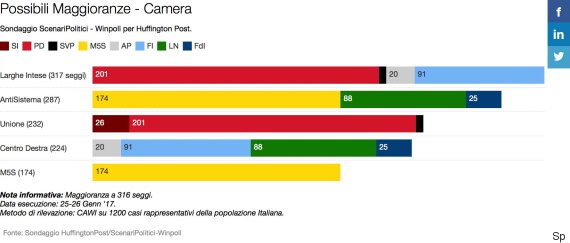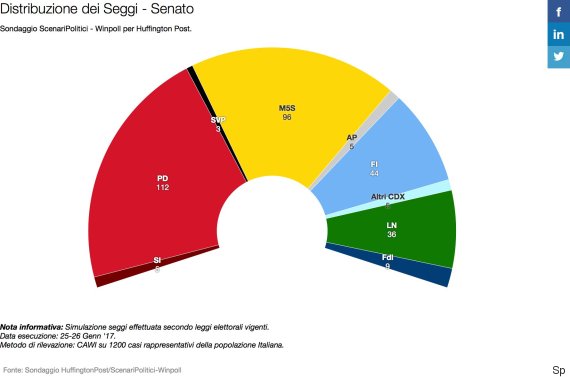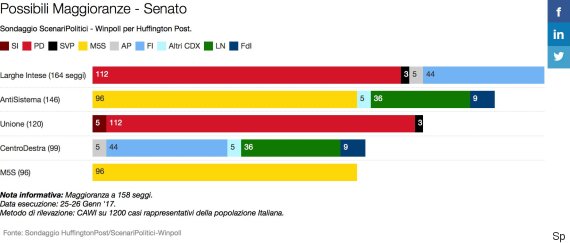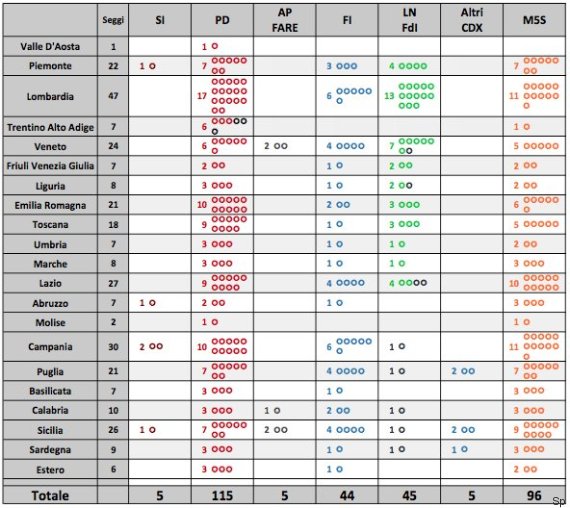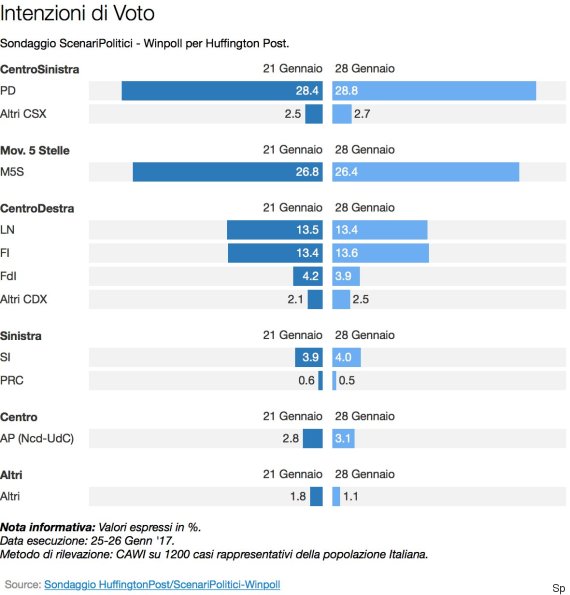Alla fine il Vaticano, per i cinesi, potrebbe costare meno, e contare di più, del Milan e dell’Inter, di Matt Damon e “The Great Wall”, il kolossal cinematografico sulla Grande Muraglia.Nella gigantesca e dispendiosa operazione “simpatia” che il governo di Pechino ha messo in campo world-wide, dal football ai blockbuster, per colmare il proprio deficit di soft power, la Chiesa e il Papa rivestono un ruolo strategico e più economico, rispetto agli altri asset. Nella “lunga marcia” che ha per meta i luoghi centrali e i protagonisti apicali dell’immaginario, Roma e il romano Pontefice si collocano ai vertici della hit: target imprescindibile per chi ambisce a sviluppare un modello di egemonia culturale alternativo al Washington consensus. Unico brand che la “fabbrica del mondo” nei distretti tuttofare dal Guangdong a Shanghai non saprebbe produrre in proprio.
È questo il movente di fondo, il tapis roulant geopolitico che spinge lentamente quanto inesorabilmente a un’intesa tra il Celeste Impero e il successore di Pietro, deponendo il “fardello della storia” – espressione del Cardinale Parolin in un colloquio con il Wall Street Journal – e superando l’anacronistico diaframma che inficia il profilo di entrambi, rendendolo di fatto incompiuto.
Già, incompiuto. Poiché un cattolicesimo senza Cina, nel XXI secolo, rimarrà pure sinonimo di “universalità” – dal greco kat’olón -, ma non potrà definirsi “globalizzato”. Così come la Cina, con la sua poderosa spinta globalizzante, non può dirsi e costituire un simbolo “universale”, se sbarra le frontiere al cattolicesimo.
“Convergenze parallele” – le chiameremmo in Italia -, che hanno portato il segretario di Stato Vaticano e il presidente cinese Xi Jinping a difendere in simultanea, nel World Economic Forum di Davos, il dogma della globalizzazione, mentre Donald Trump, da Washington, lo demoliva nel discorso d’insediamento: congiuntura di eventi che annuncia e prepara un clamoroso rovescio di alleanze.
Questione di numeri: un miliardo e trecento milioni di cinesi versus un miliardo e trecento milioni di cattolici. Stessa profetica cifra. Due “eserciti popolari” fedeli e indottrinati. Agli ordini di un solo capo, circondato da una corte di mandarini, da un lato, e di porpore, dall’altro. Equazione che spiega in sintesi meglio di qualunque analisi perché Pechino non può fare a meno del Papa eppure ne ha paura. Si somigliano, si ammirano, si temono. Globalismo sinico e universalismo romano, quindi. Due dimensioni troppo complementari per non attrarsi a vicenda, sul piano della reciproca convenienza, e al tempo stesso non respingersi, nella cronica diffidenza di un negoziato interminabile. Ma non impossibile.
Demograficamente in equilibrio e diplomaticamente in stallo, la trattativa tra il Vaticano e Pechino procede alla stregua delle “ombre cinesi”, confondendo gli osservatori e nascondendo gli attori. Falsando la prospettiva e ingigantendo i problemi. Non sappiamo di conseguenza quanto durerà l’attuale impasse sulla procedura di nomina dei vescovi, che non va tuttavia considerata un rebus irrisolvibile, sottovalutando l’evoluzione del quadro politico. Anzi, se il meccanismo si è inceppato, questo si deve forse a un effetto stretch-back, cioè al tentativo di forzare i tempi e accelerare il rush finale, a rischio di scivolare sul filo d’arrivo: tentazione ricorrente in prossimità dei traguardi storici. “C’è bisogno di pazienza e perseveranza. E ci vorrà un lungo cammino, poiché abbiamo dietro di noi una storia molto, molto difficile”, ha chiosato Parolin con allusione all’ultimo stop.
L’incidente di percorso è noto: mentre a Roma si vagheggiava di accendere i fuochi d’artificio – altra specialità orientale – e bruciare le tappe, chiudendo la Porta Santa del Giubileo e aprendo i battenti della Città Proibita, Pechino bagnava le polveri e spegneva l’entusiasmo. Imponendo ed esibendo sull’altare, tra novembre e dicembre 2016, durante i riti di ordinazione di due nuovi presuli, la presenza del vescovo Paolo Lei Shiyin, eletto e consacrato senza l’input papale. Ergo scomunicato. Un sasso nell’ingranaggio binario e bonario, che aveva indotto Cina e Santa Sede a ritrovarsi ormai con tacito accordo sui medesimi nominativi. Mossa provocatoria, quindi. Ma non contraddittoria e neppure velleitaria. Messa lì volutamente a sottolineare un messaggio chiaro.
L’anomalia cinese, che nega il diritto del Pontefice – riconosciutogli pressoché in tutti gli Stati – di scegliere i vescovi in via esclusiva, si spiega infatti con il riflesso istintivo, a pelle, di un vulnus atavico. Una ferita che la Repubblica Popolare, ad onta dei suoi successi planetari, non riesce a cicatrizzare: quella dei “trattati ineguali”, cioè l’amputazione di sovranità che la Cina dovette subire nell’Ottocento, in un frangente di arretratezza tecnologica e debolezza istituzionale, cedendo alle potenze occidentali, e alle missioni cristiane, una serie di giurisdizioni speciali e zone franche, allora percepite come avamposti di colonizzazione culturale. Tutte le rivoluzioni cinesi del Novecento, al netto della loro bruta discontinuità tra collettivismo e capitalismo, e di un tributo altissimo di vite umane, dal “grande balzo in avanti” di Mao Zedong al tragico salto indietro di Piazza Tienanmen, si devono leggere in chiave unitaria come una sequenza ininterrotta di terapie d’urto, di elettroshock ideologici e politici per sollevare il gigante caduto e prevenire nuovi affronti all’indipendenza della nazione.
“Ci sono due chiese”, ha sintetizzato Parolin. Quella “ufficiale”, che ha “il problema della comunione con la Santa Sede”. E quella “cosiddetta sotterranea”, che ha invece “il problema del riconoscimento” da parte delle autorità. Stando così le cose, la soluzione potrà discendere solo da una “sanatoria” urbanistica, dove Roma legittima in blocco l’edificio gerarchico abusivo elevato in sessant’anni da Pechino e quest’ultima entra in società con il Pontefice, per così dire, lasciandogli l’imprimatur dottrinale, nonché disciplinare, ma continuando a esercitare l’imprinting sulla linea politica dei candidati all’episcopato.
Tra ombre cinesi e improvvisi annuvolamenti, gli ambasciatori di Francesco, il “Pontifex”, e i genieri del leader comunista, Xi Jinping, lavorano al progetto di un ponte a due corsie, parallele ma separate: riservate rispettivamente al Papa e al partito. A sopportare il peso del “trattato ineguale”, in tal caso, sarebbe principalmente la Santa Sede, invertendo le posizioni e i rapporti di forza di cent’anni or sono. Pareggiando i conti con la storia e regolarizzando, almeno in parte, un paesaggio ecclesiale imperniato su organismi altrove inesistenti, che fungono da longa manus del regime: l’Associazione Patriottica e il Consiglio dei Vescovi, emanazioni entrambe dell’Assemblea dei Rappresentanti Cattolici, ossia gli “stati generali” della chiesa in Cina, riuniti ogni cinque anni sotto l’egida dell’Amministrazione degli Affari Religiosi. Un convegno sui generis, all’incrocio tra dottrina e indottrinamento, giunto alla nona edizione e tenuto dal 27 al 29 dicembre in un hotel di Pechino, all’insegna dell’appeasement e senza il veto preventivo del Vaticano, a differenza del 2011.
Non è la prima volta che Francesco si mostra propenso a cedere spazi, pur di “avviare processi”, secondo il criterio cardine di tutta la sua geopolitica, teorizzato in Evangelii Gaudium, Magna Carta del pontificato: “il tempo è superiore allo spazio”. Un principio applicato a Cuba, l’inverno scorso, nell’incontro con il patriarca russo Kirill, sottoscrivendo una “Yalta” dell’ecumenismo e impegnandosi a non fare proseliti nelle altrui zone d’influenza: e nemmeno a promuovervi l’evangelizzazione. O in autunno a Lund, con i protestanti scandinavi, arrivando quasi a canonizzare Lutero e a celebrare come festa cattolica il mezzo millennio della Riforma.
Bergoglio del resto non ammira solo il passato ma il presente della Cina con le sue straordinarie performance economiche, in termini di “democrazia sostanziale”, rilevante ai suoi occhi non meno di quella formale. Il paradiso delle libertà marchiate Occidente può attendere, insomma, e affermarsi gradualmente con proprie caratteristiche made in China, se nel frattempo una leadership fa uscire dall’inferno dell’estrema povertà centinaia di milioni di uomini, adempiendo un ulteriore precetto della Evangelii Gaudium: “la realtà è più importante dell’idea”. Di rimando, anche Xi Jinping, al pari del padre della patria Sun Yat-sen, avverte il fascino modernizzatore, e moralizzatore, del cristianesimo: altrimenti non si comprende la recente, sorprendente dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri, secondo cui la Chiesa cattolica deve svolgere il compito di evangelizzare la Cina: auspicio inconcepibile nel lessico politicamente corretto dell’Unione Europea.
Tutto muove perciò nella direzione, e accelerazione, del connubio tra i due globalismi. L’uno e l’altro sonoramente anticapitalisti, a parole, ma serenamente capitalisti, nelle opere: altra peculiarità che li accomuna. Come abbiamo già scritto su queste pagine, la normalizzazione dei rapporti con l’Impero di Mezzo sancirebbe il punto di arrivo, forse l’approdo esaustivo del pontificato, colmando il vuoto nella geografia della Chiesa e completando la biografia di Francesco, papa d’Occidente con un DNA d’Oriente, dove da giovane avrebbe voluto recarsi e trascorrere la vita, impedito per ragioni di salute dai superiori. Un traguardo emotivo e anagrafico che in questo 2017 diventa imperativo e geopolitico: la Cina configura infatti la posta in gioco e la risposta obbligata di Francesco a Trump, nel riposizionamento generale delle alleanze. Di qui l’augurio per l’inizio dell’anno lunare, che comincia il 28 gennaio, rivolto ai popoli d’Oriente dalla finestra dell’Angelus.
Se lo scontro fra globalizzazione e de-globalizzazione assurge a spartiacque dell’attuale passaggio storico, le ragioni che sollecitano la Cina e il Vaticano ad allearsi, superando le storiche divisioni, non sono meno suadenti, e vincolanti, di quelle che sul fronte opposto ispirano il riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti. L’universalismo cattolico, che già con il magistero di Ratzinger ha indicato nella globalizzazione uno strumento “provvidenziale”, atto a realizzare l’unità del genere umano, può fornire al motore di Pechino l’additivo delle motivazioni spirituali, utili a non andare giù di giri, mentre ovunque si alzano muri. “Mandarini” e “porpore”, a ben guardare, rivelano singolari affinità non solo cromatiche. Un gusto agrodolce in cui prevalgono le asprezze, quando si coglie il frutto anzitempo. Ma che al momento giusto, quando viene la “pienezza dei tempi”, possiede i requisiti per esaltarsi. E confermare la bontà dell’innesto.
Notizie Italy sull’Huffingtonpost